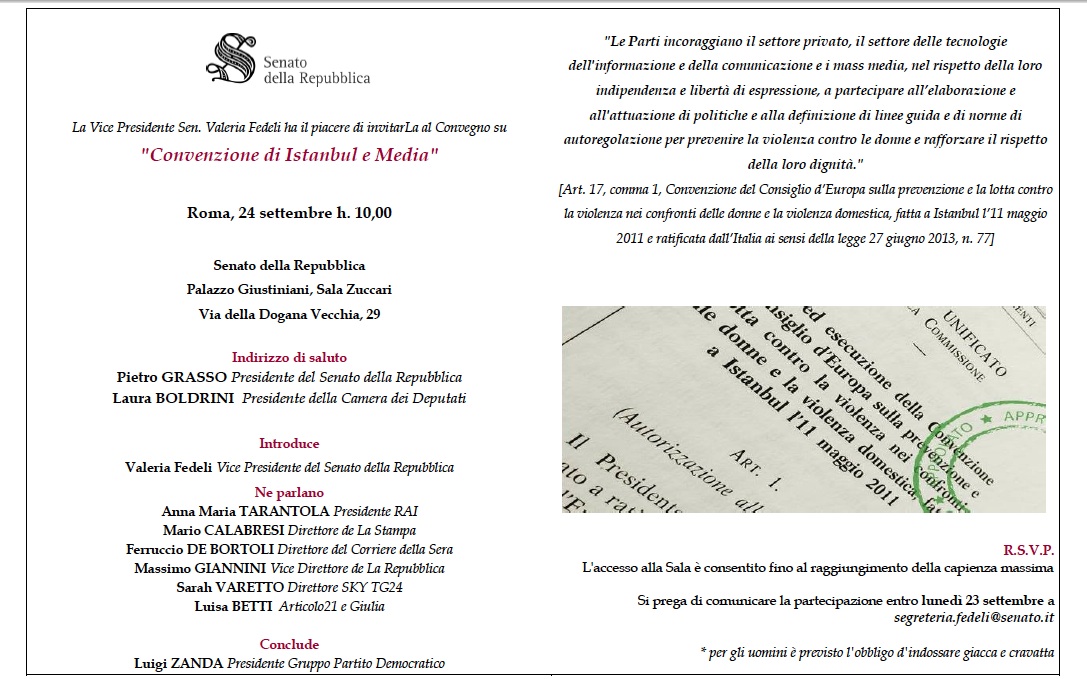Si parla continuamente di un cambiamento culturale per contrastare la violenza contro le donne in quanto fenomeno strutturale in Italia. Ma cosa significa cambiare la cultura? La cultura non è un corpo estraneo, la cultura siamo noi e si può cambiare solo partendo da noi. Per questo cambiare la cultura, significa cambiare il modo di pensare, con una consapevolezza e una conoscenza che permetta di rintracciare
stereotipi nascosti nelle pieghe profonde della società e così tanto radicati nel nostro modo di essere, da risultare invisibili

Stereotipi che sono parte integrante del nostro modo di vivere, e che pongono uomini e donne su piani di superiorità e subalternità in base al sesso, e senza alcuna altra motivazione, condizionando pesantemente le relazioni umane. Ruoli definiti e stereotipati, che sono l’humus su cui proliferano la discriminazione e la violenza di genere. E quando il pregiudizio è così interno alla società, anche l’occhio più attento non si rende conto di quanto la discriminazione delle donne sia una costante dal primo giorno in cui si nasce femmina. Una discriminazione che è già una forma di violenza, in quanto la discriminazione di genere è già di per sé una violenza: un oggetto da conquistare, possedere, controllare.
La violenza maschile contro le donne però non è un fenomeno né nuovo né solo italiano
E i dati dell’Onu ci dicono che nel mondo 7 donne su 10 subiscono violenza nel corso della vita, e che 600 milioni di donne vivono in nazioni che non considerano questa violenza un reato: una violazione di diritti umani planetaria. Dati su cui si sono concentrati a livello internazionale le Nazioni Unite, che quest’anno hanno siglato una storica carta contro la violenza su donne e bambine (Commission on the Status of Women – CSW, 8/15 marzo), e il Consiglio d’Europa con la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, redatta a Istanbul nel maggio 2011: organi internazionali che hanno sentito il bisogno di dare disposizioni organiche in merito, previa consultazione di Ong, delineando chiaramente sia i termini in cui questa violenza si manifesta, sia le forme di contrasto.
A questo si aggiungano le morti delle donne in quanto donne: il femmicidio (da non confondere col femminicidio), su cui nel novembre 2012 a Vienna, l’Academic Councilon United Nations System (ACUNS), ha redatto un documento dove esperte internazionali, come Diana EH Russell (criminologa statunitense che ha coniato il termine), hanno discusso della radice di genere delle varie forme di violenza contro le donne fino alla loro uccisione in quanto tali, stabilendo che «il femmicidio è l’ultima forma di violenza contro le donne e le ragazze», che «le sue molte cause sono radicate nelle relazioni di potere storicamente ineguali tra uomini e donne, e nella discriminazione sistemica basata sul genere».
 La Special Rapporteur dell’Onu sulla violenza di genere, Rashida Manjoo, ha infine presentato al Consiglio dei diritti umani di Ginevra nel giugno del 2013, il primo Rapporto tematico sul femminicidio, adottando il termine sociologico coniato da Marcela Lagarde, che indica «la forma estrema di violenza di genere contro le donne, prodotto della violazione dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato, attraverso varie condotte misogine che comportano l’impunità delle condotte poste in essere, tanto a livello sociale quanto dallo Stato e che, ponendo la donna in una situazione indifesa e di rischio, possono culminare con l’uccisione o il tentativo di uccisione della donna stessa, o in altre forme di morte violenta di donne e bambini, di sofferenze psichiche e fisiche comunque evitabili, dovute all’insicurezza, al disinteresse delle Istituzioni e all’esclusione dallo sviluppo e dalla democrazia».
La Special Rapporteur dell’Onu sulla violenza di genere, Rashida Manjoo, ha infine presentato al Consiglio dei diritti umani di Ginevra nel giugno del 2013, il primo Rapporto tematico sul femminicidio, adottando il termine sociologico coniato da Marcela Lagarde, che indica «la forma estrema di violenza di genere contro le donne, prodotto della violazione dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato, attraverso varie condotte misogine che comportano l’impunità delle condotte poste in essere, tanto a livello sociale quanto dallo Stato e che, ponendo la donna in una situazione indifesa e di rischio, possono culminare con l’uccisione o il tentativo di uccisione della donna stessa, o in altre forme di morte violenta di donne e bambini, di sofferenze psichiche e fisiche comunque evitabili, dovute all’insicurezza, al disinteresse delle Istituzioni e all’esclusione dallo sviluppo e dalla democrazia».
Una violazione dei diritti umani come conseguenza dei rapporti “sbilanciati” tra i sessi, ribadita ormai non solo dai movimenti femministi e/o femminili, ma da un vasto panorama internazionale impegnato su un fenomeno che è trasversale a culture e società, anche diverse tra loro, ed esteso a ogni classe sociale e a ogni età. La Convezione di Istanbul, oltre a condannare «ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica», riconosce che il raggiungimento dell’uguaglianza è un elemento chiave per prevenire la violenza. Riconoscendo «la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere», la Convenzione insiste sulla prevenzione e sulla protezione attuabile attraverso una fitta e articolata rete di sostegno per le donne e i minori che le accompagnano, ma soprattutto chiarisce quanto l’elemento culturale sia fondamentale, nel senso che si possono fare le migliori leggi del mondo ma se non cambia la testa, queste leggi possono anche rimanere inapplicate (come già succede in Italia e come sottolineato dalla Special Rapporteur dell’Onu, Rashida Manjoo, nelle sue raccomandazioni al nostro Paese).
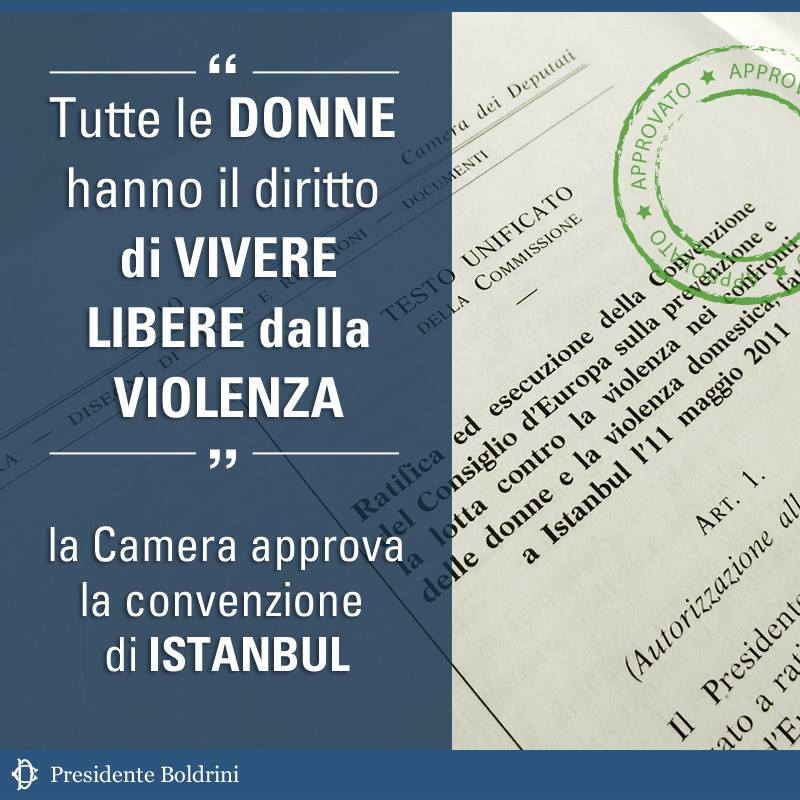 La Convenzione di Istanbul stabilisce esattamente cosa si intenda per violenza contro le donne: «Con l’espressione violenza nei confronti delle donne – si legge – si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano, o sono suscettibili di provocare, danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata». Ma avere una chiara percezione di questa violenza, oltre a un’acquisizione ufficiale dei dati e un monitoraggio sull’efficienza dello Stato che sono a oggi inesistenti in Italia, occorre una narrazione del fenomeno che sia fuori dagli stereotipi, che sono la spinta principale a una sottovalutazione del problema che influenza non solo l’opinione pubblica ma anche gli addetti ai lavori: come dimostrano il
La Convenzione di Istanbul stabilisce esattamente cosa si intenda per violenza contro le donne: «Con l’espressione violenza nei confronti delle donne – si legge – si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano, o sono suscettibili di provocare, danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata». Ma avere una chiara percezione di questa violenza, oltre a un’acquisizione ufficiale dei dati e un monitoraggio sull’efficienza dello Stato che sono a oggi inesistenti in Italia, occorre una narrazione del fenomeno che sia fuori dagli stereotipi, che sono la spinta principale a una sottovalutazione del problema che influenza non solo l’opinione pubblica ma anche gli addetti ai lavori: come dimostrano il
70% dei femminicidi avvenuti lo scorso anno in Italia già segnalati a rischio e quindi evitabili

Ma alcune importanti indicazioni della Convezione di Istanbul, erano già state indicate, in maniera vincolante, dalle Raccomandazioni del Comitato Cedaw all’Italia – che sorveglia l’applicazione della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne ratificata dal nostro Paese nell’85 (con adesione al Protocollo opzionale nel 2002) – e anche in quelle della Special Rapporteur dell’Onu sulla violenza di genere, Rashida Manjoo. E proprio perché lo smantellamento di una rappresentazione stereotipata è fondamentale nell’impatto culturale, tra le varie indicazioni, nei tre testi – due rivolti all’Italia e uno ratificato dal nostro Paese e quindi da implementare – ci sono indicazioni riguardo ai media e all’informazione.
Nelle raccomandazioni della Cedaw viene raccomandato all’Italia di «predisporre in collaborazione con un’ampia gamma di attori, comprese le organizzazioni femminili e le altre organizzazioni della società civile, delle campagne di sensibilizzazione attraverso i media (…), affinché la violenza nei confronti delle donne venga considerata socialmente inaccettabile». Nelle raccomandazioni Onu di Rashida Manjoo, si raccomanda di
«formare e sensibilizzare i media sui diritti delle donne compresa la violenza di genere per una rappresentazione non stereotipata nei mezzi di comunicazione»
E nella Convenzione di Istanbul, si chiede, all’art.17, che «Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all’elaborazione e all’attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità». È quindi opportuno riflettere su come tali indicazioni siano implementabili nel nostro Paese in relazione ai media, ma soprattutto rispetto all’informazione di giornali, telegiornali, speciali e programmi d’informazione tramite stampa, tv e web. Perché se è vero che la percezione della violenza è uno dei nodi fondamentali, l’informazione che – a differenza di fiction o della pubblicità – si pone come “oggettiva”, influenza in maniera diretta la percezione di quel problema come fosse “super partes”.
Un’informazione che può procurare danni gravi
Quando ho cominciato a monitorare l’informazione italiana con un “occhio di genere”, e occupandomi già di violenza su donne e minori, ho visto che malgrado in Italia l’80% della violenza fosse violenza domestica e malgrado la maggior parte degli autori di femmicidio fossero membri maschi della famiglia italiana (mariti, fidanzati, ex o partner respinti), di cui solo il 10% con problemi psichici accertati, si parlava sempre di “raptus, infermità mentale, gelosia, delitto passionale, stress dovuto al lavoro o alla perdita del lavoro”, e si tracciava un profilo della donna che ricalcava stereotipi comuni, quasi a suggerire una complicità della donna stessa la quale, avendo provocato, tradito, esasperato, respinto l’uomo, si era ritrovata uccisa.

Quando si trattava di un’uccisone dopo una lunga serie di maltrattamenti gravi in famiglia, nei giornali spesso il titolo riportava un’attenunate psichiatrica dell’autore e di solito il background culturale nell’illustrazione dei fatti, richiamava agli stereotipi femminili. Citando il Rapporto Ombra presentato dalla Piattaforma Cedaw a New York nel 2011: «I media spesso presentano gli autori di femmicidio come vittime di raptus e follia omicida, ingenerando nell’opinione pubblica la falsa idea che i femmicidi vengano perlopiù commessi da persone portatrici di disagi psicologici o preda di attacchi di aggressività improvvisa. Al contrario,
meno del 10% di femmicidi è a causa di patologie psichiatriche e meno del 10% è stato commesso per problemi economici
La violenza sulle donne – femminicidio (che in Italia ha ancora un altissima percentuale di sommerso), era trattata come un fatto di cronaca isolato e sporadico, attraverso una narrazione che per rendere più “appetibile” il racconto andava a scavare nel “torbido”, indugiando su aspetti morbosi per interessare e facendo leva su stereotipi culturali, senza dare un quadro d’insieme. Trasformando anche la vittima in offender e minimizzando la gravità del reato commesso.
 Ma chi informa deve essere informato e non può prescindere da una formazione e una preparazione adeguata su temi che non sono di serie B, e che non possono essere improvvisati, soprattutto se si tratta di professionisti dell’informazione, come siamo appunto noi giornalisti e giornaliste. Con queste premesse, è iniziato il lavoro sul femmicidio-femminicidio nella Rete nazionale delle giornaliste italiane (Giulia) e ciò succedeva quando ancora nessuno, su stampa e tv, parlava di femmicidio/femminicidio.
Ma chi informa deve essere informato e non può prescindere da una formazione e una preparazione adeguata su temi che non sono di serie B, e che non possono essere improvvisati, soprattutto se si tratta di professionisti dell’informazione, come siamo appunto noi giornalisti e giornaliste. Con queste premesse, è iniziato il lavoro sul femmicidio-femminicidio nella Rete nazionale delle giornaliste italiane (Giulia) e ciò succedeva quando ancora nessuno, su stampa e tv, parlava di femmicidio/femminicidio.
Il tam tam che è scaturito da quel lavoro, in Giulia e poi con Articolo21, ha portato l’informazione a concentrarsi in maniera differente sul problema, perché le giornaliste cercavano con grande tenacia di allargare gli orizzonti nelle redazioni in cui lavoravano. È stato così che dall’inizio del 2012 le giornaliste di molte testate italiane, hanno cominciato a dare una prospettiva diversa al trattamento della violenza contro le donne all’interno dell’informazione, al fine di argomentare il fenomeno con una prospettiva che superasse il pregiudizio discriminatorio, sia sulle donne sia rispetto alla considerazione di un argomento “inferiore” e privo di una sua dimensione specifica.
Ma c’è un problema che è venuto a galla in tutta evidenza quando la presidente della camera, Laura Boldrini, vittima di attacchi sessisti violenti, si è mossa su questo, ed è stata gridata la parola “censura” malgrado lei non l’avesse nenache proferita. Ciò è successo perché la sottovalutazione di quello che rappresenta in realtà la violenza sessista e discriminatoria contro le donne, persiste. Oggi, quello che bisognerebbe evitare è infatti il meccanismo di speculazione strumentale che tratta il femmicidio e il femminicidio come un passepartout che fa notizia e su cui anche chi non ha strumenti né competenze, può avventurarsi.
 Con modi meno sfacciati e meno aggressivi di prima, ma pur sempre in maniera superficiale, chi schiaffa in prima pagina il termine “femminicidio” senza cognizione di causa, continua a sottovalutarne la portata. Un pericolo, perché il pregiudizio della discriminazione di genere permane, e si riflette nel sostegno sotterraneo di una cultura che in ambito giudiziario trova ancora donne che non sono credute quando denunciano una violenza. Donne che rischiano di essere rivittimizzate in tribunale, e che si ritrovano impossibilitate a un accesso sicuro alla giustizia a causa dell’impreparazione degli “addetti ai lavori”.
Con modi meno sfacciati e meno aggressivi di prima, ma pur sempre in maniera superficiale, chi schiaffa in prima pagina il termine “femminicidio” senza cognizione di causa, continua a sottovalutarne la portata. Un pericolo, perché il pregiudizio della discriminazione di genere permane, e si riflette nel sostegno sotterraneo di una cultura che in ambito giudiziario trova ancora donne che non sono credute quando denunciano una violenza. Donne che rischiano di essere rivittimizzate in tribunale, e che si ritrovano impossibilitate a un accesso sicuro alla giustizia a causa dell’impreparazione degli “addetti ai lavori”.
Il punto cruciale è allora la percezione della violenza nella sua reale gravità: lo smantellamento di una cultura della “sottovalutazione della violenza” che traspare ovunque con conseguenze enormi, e in cui si rischia di far passare come normalità, un danno o una violazione. Per questo l’informazione ha un ruolo fondamentale: perché se i media sostengono questa cultura della sottovalutazione – che poggia sul pregiudizio della discriminazione di genere – è ovvio che anche la percezione dell’opinione pubblica sarà tale, e questo sosterrà a sua volta anche la rivittimizzazione nei tribunali, nelle forze dell’ordine, tra operatori.
Pubblicare articoli negazionisti sulla violenza contro le donne o lasciare che giornalisti tematiche si avventurino senza strumenti, può essere pericoloso
È quella che viene chiamata vittimizzazione secondaria e che in questo caso è fatta attraverso i media, quell’arma affilatissima che proviene dal pregiudizio ma anche dall’illusione che basta essere “brave persone” o “bravi professionisti”, per essere oggettivi e bilanciati. Trattare le donne come se fossero vittime indifese da proteggere, perenni inadeguate, mettere sullo stesso piano la violenza maschile con la reazione femminile di fronte a una violenza fisica e/o psicologica, dare voce all’autore della violenza senza dotarsi di strumenti di approccio e analisi adeguate, può essere considerata causa di una rivittimizzazione mediatica. Una impreparazione che ha tenuto ben lontani i giornalisti da molti centri antiviolenza, i quali, per molto tempo, si sono rifiutati di dare in pasto le storie delle donne come se fosse materiale da scoop: un gap, tra la realtà della violenza e l’informazione che se ne dava, che oggi stiamo cercando faticosamente di riempire e su cui non vorremmo tornare indietro.
 Dare la sensazione che l’uomo è un poveretto respinto da una donna che giocava coi suoi sentimenti di uomo ferito, senza chiamare quel tipo di situazione col suo vero nome, cioè violenza psicologica, è molto più pericoloso di quanto si possa pensare. Perché quello che è importante non è soltanto il racconto dei fatti, ma l’imparare a raccontarli soprattutto in un contesto culturale così discriminatorio per le donne come quello italiano, dove l’idea che continua a passare è che comunque un certo tipo di atteggiamenti, anche violenti, siano un ingrediente normale dei rapporti intimi: una convinzione che nei tribunali, nelle caserme, e in alcune perizie psicologiche (CTU), espone la donna a grave rischio.
Dare la sensazione che l’uomo è un poveretto respinto da una donna che giocava coi suoi sentimenti di uomo ferito, senza chiamare quel tipo di situazione col suo vero nome, cioè violenza psicologica, è molto più pericoloso di quanto si possa pensare. Perché quello che è importante non è soltanto il racconto dei fatti, ma l’imparare a raccontarli soprattutto in un contesto culturale così discriminatorio per le donne come quello italiano, dove l’idea che continua a passare è che comunque un certo tipo di atteggiamenti, anche violenti, siano un ingrediente normale dei rapporti intimi: una convinzione che nei tribunali, nelle caserme, e in alcune perizie psicologiche (CTU), espone la donna a grave rischio.
La violenza psicologica nei rapporti d’intimità, non è una semplice conflittualità
Se il problema è strutturale, l’informazione e la narrazione mediatica di questa violenza, diventa uno dei fattori principali per il cambiamento. Per queste ragioni, non basta essere “sensibili” all’argomento ma bisogna conoscerlo, bisogna essere preparati, studiare, ed è fondamentale che la formazione valga, così come per i giudici, forze dell’ordine, avvocati, psicologi, assistenti sociali, anche per i giornalisti che si vogliano occupare di questi temi. Risolvere il problema culturale anche attraverso una corretta informazione, è il nodo: ma lo dobbiamo fare da sole continuando a punzecchiare direttori e caporedattori? Io farei un passo in più perché vorrei che in questo momento gli uomini, che nelle redazioni italiane occupano la maggioranza dei posti di comando, scegliessero di ascoltarci prendendo in seria considerazione le modalità da noi indicate, non solo perché li riguarda ma perché è una responsabilità nei confronti di tutta l’umanità.
 Per dare una corretta informazione, che non sia soltanto attraverso i seppur utilissimi e validissimi blog e rubriche di esperte, bisognerebbe entrare a pieno titolo nel tessuto vivo del giornale, avviando un processo di trasformazione anche dentro le redazioni. Redazioni che vorremmo fossero attrezzate, non solo con un vademecum o linee di condotta, ma conredattrici e redattori, formati su questi temi che possano non solo evitare pericolosi scivoloni ma anche produrre una nuova cultura, un nuovo modo di vedere le cose. Una specie di “occhio di genere” che attraverso giornalisti e giornaliste formati sulla materia, possano nei vari desk rintracciare e stimolare un nuovo linguaggio, evitando non solo il neutro, ma anche mettendo in luce differenti aspetti di un certo avvenimento.
Per dare una corretta informazione, che non sia soltanto attraverso i seppur utilissimi e validissimi blog e rubriche di esperte, bisognerebbe entrare a pieno titolo nel tessuto vivo del giornale, avviando un processo di trasformazione anche dentro le redazioni. Redazioni che vorremmo fossero attrezzate, non solo con un vademecum o linee di condotta, ma conredattrici e redattori, formati su questi temi che possano non solo evitare pericolosi scivoloni ma anche produrre una nuova cultura, un nuovo modo di vedere le cose. Una specie di “occhio di genere” che attraverso giornalisti e giornaliste formati sulla materia, possano nei vari desk rintracciare e stimolare un nuovo linguaggio, evitando non solo il neutro, ma anche mettendo in luce differenti aspetti di un certo avvenimento.
Come esiste il giornalista di esteri, di interni, sarebbe auspicabile che della violenza sulle donne e sui minori non si occupasse né il cronista né il redattore di turno, ma qualcuno che sa maneggiare l’argomento. Lo mettereste voi uno che fa sport a fare la pagina di economia? Credo di no. Auspicare che le direzioni dei giornali si avvalgano di alcune figure professonali da inserire direttamente nel tessuto del giornale e che queste figure possano avere anche ruoli di responsabilità, sarebbe un grande passo avanti.
 Ma si potrebbe parlare di vero e proprio salto, se oltre agli argomenti, ci si attrezzasse per promuovere la soggettività femminile anche all’interno delle redazioni, tanto da scegliere la donna a parità di capacità con l’uomo. Come indicano le Raccomandazioni Cedaw, è indispensabile nel nostro Paese «adottare ulteriori misure per accelerare il raggiungimento della piena ed eguale partecipazione delle donne nei processi decisionali, a tutti i livelli e in tutti i settori», senza dimenticare di «sviluppare e applicare sistemi di valutazione del lavoro, basati su criteri di genere». Le donne oggi sono l’avanguardia di un profondo cambiamento culturale che porterà vantaggi all’intera società e alle nuove generazioni, maschi o femmine che siano.
Ma si potrebbe parlare di vero e proprio salto, se oltre agli argomenti, ci si attrezzasse per promuovere la soggettività femminile anche all’interno delle redazioni, tanto da scegliere la donna a parità di capacità con l’uomo. Come indicano le Raccomandazioni Cedaw, è indispensabile nel nostro Paese «adottare ulteriori misure per accelerare il raggiungimento della piena ed eguale partecipazione delle donne nei processi decisionali, a tutti i livelli e in tutti i settori», senza dimenticare di «sviluppare e applicare sistemi di valutazione del lavoro, basati su criteri di genere». Le donne oggi sono l’avanguardia di un profondo cambiamento culturale che porterà vantaggi all’intera società e alle nuove generazioni, maschi o femmine che siano.
________________________________________________________________________
Inchiesta di Luisa Betti presentata al convegno Convenzione di Istanbul e Media presso la Sala Zuccari al Senato.